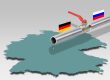19 Febbraio 2022 Gavino Piga
La crisi pandemica forse non insegnerà nulla, ma di certo rivela moltissimo. Di noi, dei nostri tempi, e non solo del nostro modo di rapportarci alla malattia o al pericolo. Rivela, più in profondità, la tendenza delle nostre società – sedicenti libere – a quella «vasta standardizzazione e “disambiguazione” del mondo» cui si vorrebbe subordinare tutto e tutti.
Da qui parte il giornalista tedesco Paul Schreyer nel suo ultimo, brillantissimo saggio, Cronaca di una crisi annunciata – Come il coronavirus ha cambiato il mondo, edito in Italia dalla coraggiosa casa di produzione OvalMedia (qui il Trailer Book). E come descrivere meglio la prospettiva cui le masse globali da tempo, nella più terrificante inconsapevolezza, sono inchiodate? Sì, proprio quell’innocente operazione – Word Sense Disambiguation – nota ai più grazie a Wikipedia e che ci consente di precisare il significato di una parola qualora possa averne diversi a seconda del contesto, più che strumento di chiarificazione è ormai, nella sovversione concettuale che ci domina, un utile paradigma del totalitarismo comunicativo senza cui tutto in questi due anni sarebbe stato diverso.
Non è un caso, e non è un’esagerazione: costruire inventari di senso oggi, nell’urgenza di predisporre un cosmo di Intelligenze Artificiali (che è il motivo per cui s’investono cospicui fondi nel settore della linguistica), non ha nulla a che vedere con l’erudizione dei buoni maestri d’un tempo. Si tratta piuttosto di riprogrammare artificialmente il linguaggio su base algoritmica. Di operare sul senso per sottrazione, per far corrispondere ogni pugnetto di suoni a categorie merceologiche precise, ma soprattutto a una sola delle caselle “vero” o “falso” (non necessariamente sempre la stessa: si vede alla bisogna), con conseguente divisione della società in buoni e cattivi. Non per amore di verità, ovviamente. Semmai perché una “verità” così disambiguata e standardizzata combacia meglio col potere. Proprio come le moltitudini dei “buoni”.
Ecco quindi la narrazione mediatica impegnata a disinfestarsi dalla disinformazione, cioè a ristrutturarsi su un Indice del senso il cui unico criterio – celebrato dai chierichetti della scienza pret à penser – è un sommo Bene tratto dall’agenda dei centri della finanza mondiale. E come esige la dura legge del planner, ogni unità deve essere immediatamente traducibile in certezza operativa, facile da ricollocare a seconda non del contesto ma delle esigenze (di chi muove le pedine). Chiara e inequivocabile come devono esserlo gli ordini. Gli imput. Ma da qui anche l’ossessiva crociata contro il complottismo, sotto la cui etichetta passa chiunque non si arrenda all’assioma del «tutto è come sembra» e voglia attentare all’armonia dell’ordine regnante scorgendovi – ancora una volta – polisemie pericolosamente “ambiguanti”. O da disambiguare operando sulla profondità, anziché sulla superficie.
La pandemia – come fatto politico e culturale, come regolatore di equilibri, come futuro sedimento in una coscienza collettiva assai ampia – è stata il fragoroso approdo di tutto questo. Di quest’intreccio di scientismo fideistico, verità totalitarie, volontà standardizzante. Se ne è alimentata e ne ha realizzato l’implementazione definitiva.
Quanto all’antidoto, Schreyer riesce a darcelo – con rara perizia stilistica, da giornalista abituato a misurarsi sui fatti – nelle quasi duecento pagine della sua cronaca.
Sì, cronaca, come da titolo programmaticamente antitetico alla cultura dello storytelling. Date le premesse, del resto, la chiave con cui il giornalista sceglie di leggere la pandemia non poteva che essere questa. Non arrendersi alla superficie. Investigare, sondare la genealogia di parole e fatti, spesso svelandone il rovescio: è quel perfido meccanismo per cui negli USA il rassicurante Centro per la Sicurezza Sanitaria un tempo si chiamava Centro di Studi per la Biodifesa Civile. Senza che la ri-nominazione ne abbia modificato struttura e scopo, ma questo poco importa in una società a cui l’idea della biosicurezza è stata venduta nella confezione asettica, patinata, monosemica di cui dicevamo. Quasi fosse un valore univoco per tutti. Come se il pericolo biologico non fosse per alcuni opportunità. Per multinazionali pronte a ricavarne profitti enormi, ad esempio, o per governi interessati a testare armi potenzialmente utilizzabili. Niente: nel credo scientista, lo sappiamo, ogni cosa, debitamente disambiguata e certificata, deve essere ciò che sembra (o vien fatta sembrare). La complessità e la densità devono essere scomposte, riformulate in linguaggio binario.
Se però ci si azzarda a leggere la crisi da coronavirus alla luce di questa catena polisemica – sanità e biodifesa, virus e potenziali armi biologiche – tutto cambia. Ci si ritrova catapultati in uno scenario in cui esistono strategie multilivello inesorabilmente (molto ambiguamente) intrecciate. Ed è appunto questa la sfida di Schreyer. Ne nasce un’accurata indagine su istituzioni e ricerche in campo sanitario (e pandemico), in cui «la pianificazione della protezione dal pericolo» è andata «spesso di pari passo con la ricerca per la produzione di quello stesso pericolo, cioè lo sviluppo di armi di distruzione di massa». A partire dall’imponente apparato costruito fin dagli anni Quaranta negli USA – con epicentro a Fort Detrick – ufficialmente per scopi di biodifesa (ma anche di esperimenti segreti su ignari cittadini: dai patogeni diffusi sulla metropolitana di New York nel 1966 alla vaccinazione obbligatoria contro l’antrace sperimentata su due milioni di soldati etc.).
Un apparato così imponente da sopravvivere alla guerra fredda – sotto il cui pretesto aveva prosperato per un abbondante quarantennio – e confermarsi pilastro della strategia americana profonda, alla ricerca disperata di nuovi nemici dopo il crollo dell’URSS per poter simulare ragioni di esistenza («ho finito i diavoli» disse Colin Powell nel 1991). Di qui la lotta al terrorismo internazionale, che non comincia nel 2001 (si pensi al progetto di legge presentato da Joe Biden nel 1995, osteggiato e poi sbloccato dopo l’attentato ad Oklahoma City) e che fin da subito si riaggancia alla propaganda sulle armi di distruzione di massa – biologiche in primis – come Schreyer documenta passo per passo. «Le armi biologiche» – avvertiva del resto, sempre nel 1995, l’ex ufficiale Robert Kadlec – «sono le uniche armi di distruzione di massa che si possono utilizzare in ogni tipo di conflitto. Se venissero impiegate, e fatte passare però per epidemie localizzate o scoppiate naturalmente, il loro uso potrebbe essere mascherato in modo credibile». Nulla che i suoi superiori non sapessero bene, e da molto tempo.
Ma non solo loro. L’intreccio di interessi privati che negli USA ha sostenuto istituzioni come il già citato Center for Health Security (destinato a guidare l’emergenza Covid) o la School of Public Health (poi non a caso Bloomberg School of Public Health) viene tracciato da Schreyer con straordinaria chiarezza. Fino a quel 1999 in cui, mentre il Pentagono varava il Project Bacchus, «militari, burocrati e scienziati ambiziosi» riuniti al Crystal Gateway Marriott di Washington convennero che il tema della biosecurity avrebbe potuto garantire il sostentamento di tutti loro se solo fossero riusciti a convincere politici, opinione pubblica e grandi finanziatori dell’importanza della minaccia bioterroristica, attraendo fondi potenzialmente enormi. Non solo dalle fondazioni, ma anche dall’industria farmaceutica. Il gran mercato della sicurezza nazionale, insomma, era ormai aperto. Ma anche la saldatura fra politiche sanitarie e della difesa diveniva ufficiale: «Per la prima volta, il ministero della Salute entra a far parte dell’apparato di sicurezza degli Stati Uniti» proclamava con l’occasione l’allora coordinatore nazionale antiterrorismo Richard Clarke, annunciando l’acquisto di medicinali speciali come scorta di tutela della popolazione e il progetto di sviluppo di nuovi vaccini e farmaci.
Su questo crinale si snoda tutta la serie di simulazioni – teatralizzazioni predittive, con sceneggiature ad hoc – che dalle conferenze washingtoniane del 1999 e del 2000 a Dark Winter (2001), Atlantic Storm (2005), Clade X (2017) ed Event 201 (2019) comincia a innervare scenari possibili con un lessico e un campionario di situazioni destinate di fatto a sconvolgere il mondo nel 2020: la quarantena e le risorse per farla rispettare, il divieto di assembramenti, la lotta alle «informazioni pericolose» sul web, la chiusura dei confini, i regolamenti di emergenza per le vaccinazioni di massa, i test diagnostici, i lockdown. Ma anche la distopia del Lock Step. Tutti tasselli di ipotesi lungamente testate e discusse in una storia che Schreyer documenta con la dovizia di un appassionato cronista. E dove c’è posto perfino per gli interrogativi che tutti noi oggi ci poniamo con angoscia: «In che misura il governo può e deve violare le libertà civili? In quali condizioni si possono esercitare questi poteri?». I partecipanti alla seconda conferenza del Center for Civilian Biodefense Studies se lo chiedevano già vent’anni fa. Perché nessuna possibilità poteva essere trascurata.
Il tutto, dentro una scena globale in cui si giocavano delicati equilibri geopolitici o si verificavano clamorose fratture: gli attentati al World Trade Center e i successivi attacchi all’antrace, ad esempio, in seguito ai quali la questione della biosecurity sarebbe stata «deliberatamente istituzionalizzata e internazionalizzata» con l’emergere di strutture transnazionali incaricate di «sincronizzare i piani politici nazionali di reazione alle epidemie». O l’elezione di Donald Trump proprio alle porte di Clade X. E la crisi della NATO o le iniziative di Gates e altri filantropi. E i paralleli piani per il controllo demografico, e il terremoto dei mercati finanziari del 2019.
C’è tutto, insomma, nell’indagine di Schreyer, e tutto è raccontato fonti alla mano, nel dettaglio, nel dritto e nel rovescio. Come ogni cronista dovrebbe fare. Fino all’impressionante catalogo di mistificazioni che ha soverchiato gli ultimi due anni. Ma soprattutto c’è il radicarsi progressivo del racconto della paura. Di una «paura strutturante», come ebbe a dire Attali nel 2009 al manifestarsi dell’influenza suina, perché – soggiungeva – «la storia ci insegna che l’umanità progredisce in maniera significativa soltanto quando ha davvero paura».
Dunque è tutta una grandiosa cospirazione? Non esattamente. Anche qui Schreyer cerca la via della maggiore apertura ma anche della maggiore complessità: «Il mondo non è né chiaramente organizzato né chiaramente caotico, ma è un intreccio abbagliante, impenetrabilmente complesso, mai del tutto comprensibile, di alleanze che si creano e si sciolgono di continuo, di piani strategici e di coincidenze sfortunate (o anche fortunate)» scrive. E da cronista fa l’unica cosa che può: mettere in sequenza fatti e presentarli al lettore, senza pregiudizi o omissioni. Il che è poi l’unico modo per sfuggire a quella standardizzazione del mondo di cui dicevamo. E per non restare prigionieri della tentazione dell’ordine perfetto che porta sempre alla stessa trappola, che sia la verità disambiguata del potere o che sia quella speculare di certo cospirazionismo. L’unico modo, insomma, per non essere Bill Gates. La cui convinzione di essere un filantropo nasce in fondo dalla presunzione che il migliore (o anche l’unico) dei mondi possibili sia quello contenuto nel suo planner personale.
Più che da deliberate intenzioni luciferine – suggerisce insomma Schreyer – la tensione a standardizzare il mondo nasce da un sistema operativo difettoso, ma potentissimo. Calcificato in visione del mondo che tenta di riprodursi in ogni area della conoscenza. I suoi stessi fautori, in fondo, ne sono psicologicamente vittime (il che non giustifica ma aiuta a spiegare). Del resto, se il linguaggio deve essere oggi la superficie di sé stesso, scorporato e ricombinato in unità monosemiche da incasellare a piacimento su una piattaforma di pianificazione aziendale è perché, a monte, così è stato di ogni possibile sapere. Ad essere stata parcellizzata è anzitutto la «rete della vita», resa materia inerte di cui «modificare e riassemblare arbitrariamente» i nodi, col bisturi di «una ricerca scientifica superspecializzata e di una medicina digitale ad alte prestazioni». Sempre Schreyer. Che poi cita Hauke Ritz, giornalista e filosofo: «Le scienze naturali si fondano sulla tacita tesi secondo cui chi vive appare vivo solo perché, a causa della sua complessità, non può ancora essere compreso completamente» perché «se la scienza fosse in grado di comprendere appieno la complessità della vita, anche la vita stessa si rivelerebbe praticamente morta». Così si spiega un percorso nato per liberare il pensiero e ora ansioso di rinchiuderlo in gabbia: «Più le scienze naturali si impegnavano a concepire il mondo come un sistema di derivazione sostanzialmente morto, privo di soggettività, di libertà e di coscienza, più cominciavano a dare vita a una nuova metafisica, che nel corso dell’industrializzazione assunse infine una forma dogmatica». Quella dell’attuale distopia tecnologica, ad esempio, che ha bisogno di ricreare una vita artefatta perché è incapace a spiegare la vita che già vive a prescindere. Come la parola mediatica ha bisogno del virtuale perché incapace di spiegare (e controllare) il reale.
Proprio perciò, dice Schreyer, «la società, tutti noi abbiamo bisogno del dubbio, di fermarci, di un’inversione di rotta che al momento sembra più urgente di qualsiasi altra cosa». Possiamo cominciare intanto col leggere libri come questo.
Gavino Piga
Comprare il libro